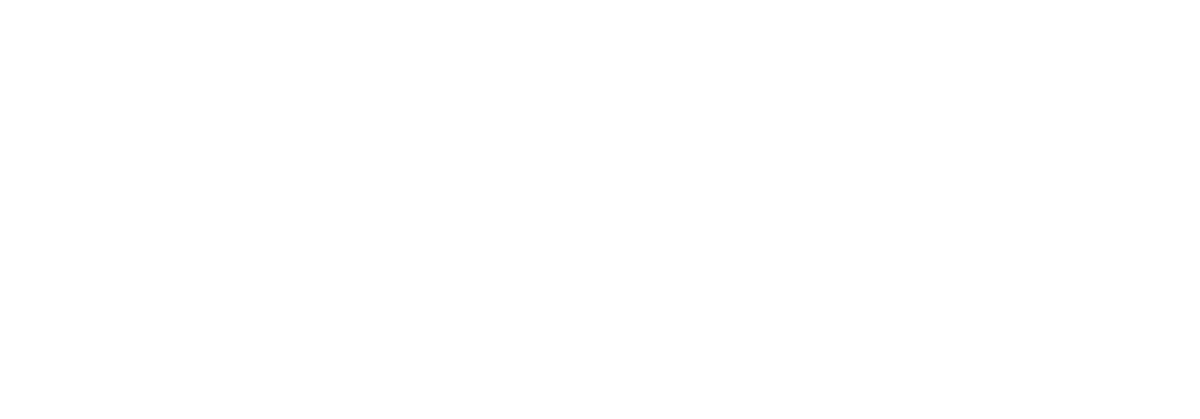Roberto Bonzio ha trasformato un’intuizione nata nella Silicon Valley in un progetto che ridefinisce il concetto stesso di frontiera. Non più confine da superare, ma soglia epistemica dove l’identità si scopre attraverso l’incontro con l’ignoto. Il suo “Italiani di Frontiera” racconta storie di connazionali che hanno saputo vedere oltre, abitare il margine come luogo di possibilità. In questa conversazione, Bonzio esplora come la curiosità, la serendipità e la narrazione possano diventare strumenti per liberare il talento e ispirare cambiamenti.
Astrid Solberg
Il suo progetto sembra trasformare il concetto di frontiera da confine geografico a soglia epistemica, dove l’identità non si definisce per opposizione ma per attraversamento. Quando racconta gli “Italiani di Frontiera”, non parla solo di migrazioni o di innovazione, ma sembra evocare una condizione esistenziale: quella di chi abita il margine come luogo di possibilità. Che cos’è, per lei, davvero, una “frontiera”? E cosa accade alla nostra idea di italianità quando la si guarda da quella soglia?
Roberto Bonzio
Vivere per un periodo a Palo Alto, tra connazionali protagonisti a Silicon Valley, mi ha fatto capire forse più del talento italiano che del mondo hi-tech. “Frontiera” è la linea del conosciuto: superarla ci fa scoprire un nuovo mondo. Non solo di qualcosa che non conoscevamo, ma anche di noi stessi. Di come reagiamo e sappiamo guardare quel che ci era ignoto, grazie a quel che abbiamo nella testa e nel cuore. E questa “italianità” sta nella capacità di combinare retaggi culturali profondi e competenze eterogenee che spesso ci fa “vedere” quel che altri non vedono. Questa versatilità degli italiani, così apprezzata all’estero, l’ho ritrovata in connazionali che hanno affrontato frontiere con l’ignoto: esploratori nel West capaci di “vedere” spiritualità, cultura e umanità in quelli che gli altri pionieri consideravano selvaggi da sterminare.
Astrid Solberg
La frontiera che lei descrive non è uno spazio da conquistare, ma una lente rivelatrice. Nel suo percorso ha spesso evocato storie di italiani capaci di riconoscere l’alterità senza dominarla, e di navigare l’ignoto con spirito creativo e attenzione umana. Come seleziona le storie che racconta? Quali criteri guidano la sua scelta di “italiani di frontiera”?
Roberto Bonzio
È proprio così: la frontiera ci aiuta a capire e conoscere noi stessi. E dovrebbe aiutarci a migliorarci. Siamo disorientati, in un’epoca di profondi sconvolgimenti, tra guerre vicine, crisi ambientale, fisica quantistica, intelligenza artificiale. Saper cambiare prospettiva e sfidare le linee del conosciuto invece di arroccarsi, scoprire senza ansia di conquista o predominio, è cruciale. Nella scelta delle storie, che prima cercavo e ora per serendipity sempre più spesso incrocio per caso, a guidarmi è la curiosità e l’emozione. Perché sono le storie che sanno emozionare ad aprirci il cuore e la mente. Una forza d’ispirazione che non si ferma a far riflettere, ma sa spingere ad agire.
Astrid Solberg
Lei evoca un’epoca in cui la crisi non è solo sistemica, ma percettiva: manchiamo di mappe, eppure suggerisce che la rotta può nascere dall’emozione. Nel suo metodo c’è anche un elemento disturbante per il paradigma razionale: la serendipity. In che modo il caso, l’incontro inatteso, interviene nella sua narrazione? E come riesce a trasformare l’imprevisto in struttura narrativa, senza cadere nel pittoresco?
Roberto Bonzio
Parto dal caso di un personaggio strambo: il sottoscritto. Mi invento un’avventura fai-da-te di sei mesi con famiglia a Silicon Valley, torno dopo decine di incontri, interviste, scoperte. Nelle prime presentazioni avevo il freddo rigore dei principi del giornalismo anglosassone. Quando casualmente due amici di grande competenza mi dissero la stessa cosa – il centro del tuo lavoro non sono le interviste ma sei tu, quel che hai fatto per andare lì e come incroci le storie – non li ringrazierò mai abbastanza. Questa personalizzazione è diventata la chiave vincente. Ho capito che la curiosità patologicamente disordinata del mio procedere, un handicap nelle redazioni, qui era un punto di forza. Seguire il cuore e l’istinto, i puntini alle spalle li unisci dopo, diceva Steve Jobs. È così che sono incappato in un’infinità di incontri senza davvero cercarli. Ma attenzione: serendipity è scoperta casuale che capita solo alle persone che sono alla ricerca, aperte al saper cogliere uno spunto che molti altri non vedono. È così che l’imprevisto diventa il perno di questi racconti senza diventare aneddotico, perché esalta la capacità del personaggio di aver saputo vedere, aver saputo interpretare.
Astrid Solberg
Nel suo racconto c’è una tensione ulteriore: la scoperta individuale non resta mai autoreferenziale, ma si fa comunità, diventa racconto condiviso. Che ruolo ha per lei la comunità nel processo di narrazione? Chi sono davvero i destinatari del suo racconto, e che tipo di trasformazione auspica in loro?
Roberto Bonzio
La più grande soddisfazione in questi anni è stato scoprire che queste storie, cariche d’empatia, hanno impatto su persone di età e provenienze diverse. E questa ispirazione non regala solo suggestioni, può aprire la mente, suggerire prospettive inedite, indurre a cambiare non solo modo di pensare ma anche di agire. Questo ha dato vita a una community internazionale di innovatori attorno al progetto. Oggi abbiamo bisogno disperato di narrazioni positive. Non siamo consapevoli di quanto viviamo immersi, tra media e social, in narrazioni negative che esaltano problemi e conflitti, non soluzioni. È una grande soddisfazione vedere come questi racconti sappiano emozionare. Spero di riuscire a farlo rivolgendomi sempre più ai giovani, che devono immaginare un futuro da protagonisti, ispirati da valori positivi.
Astrid Solberg
Lei però recupera la narrazione come forma generativa di realtà: non intrattenimento, ma “azione trasformativa”. Concludo chiedendole: qual è la responsabilità del narratore oggi? Cosa significa, nel nostro tempo, esserci nel racconto?
Roberto Bonzio
Se c’è una parola di cui si fa oggi grandissimo abuso è “innovazione”. Innovare è inteso come adozione di metodi e tecnologie nuove. Tutto vero, ma dalla mia esperienza ho scoperto che questa svolta verso il domani, in cui il futuro è assolutamente imprevedibile tra crisi politiche, ambientali, intelligenza artificiale e fisica quantistica, richiede prima di tutto fiducia in noi stessi. Per me innovare significa liberare il talento e ispirare cambiamenti, aprire spiragli inediti con le storie, nella convinzione che chi ascolta, soprattutto i più giovani, abbiano in sé le qualità per scoprire strade nuove e trovare soluzioni di cui noi più anziani non abbiamo idea. A noi il compito di togliere zavorre al loro librarsi, individuare stereotipi e modi di pensare obsoleti da abbattere, che frenano come macigni la loro creatività. Se il narratore riesce a innescare con l’emozione del racconto questo percorso creativo, ha raggiunto il proprio scopo. Essere il mentore di una svolta, vedere gli altri più liberi nell’essere se stessi.
Astrid Solberg
La frontiera, in questo quadro, non è un luogo da attraversare ma un dispositivo da disinnescare: una linea immaginaria che separa ciò che siamo da ciò che potremmo diventare. La sua visione trasforma il narratore in un disarmatore di stereotipi, un cartografo dell’invisibile. In questo dialogo abbiamo esplorato la frontiera come soglia di conoscenza, la curiosità come metodo, la serendipity come gesto epistemologico, la comunità come spazio di trasformazione e la narrazione come gesto etico. “Italiani di Frontiera” non è un progetto su chi è partito, ma su chi ha saputo aprire varchi, anche interiori. Grazie, Roberto, per aver condiviso con lucidità e passione le coordinate di questo viaggio.